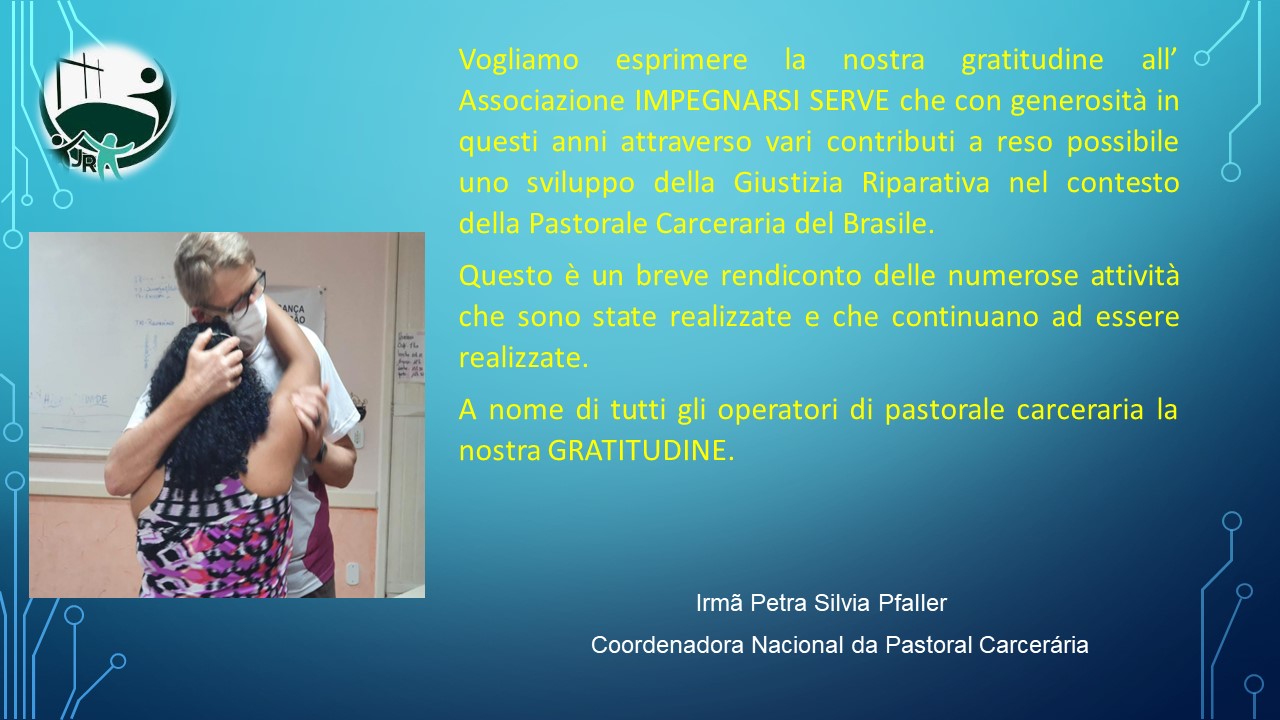Tutti siamo stati coinvolti dalla tragedia di Lampedusa e abbiamo sentito nostre le parole di papa Francesco. Riteniamo di fare un servizio nel segnalarvi due articoli “utili” per riflettere e leggere la situazione dal contesto di un esperienziale.
COSA SI PROVA AD ESSERE UN PROFUGO
di Marek Halter
da REPUBBLICA, 4/10/13
Sono stato io stesso un profugo, alla ricerca della libertà. Avevo 7 anni e fuggivo dal ghetto di Varsavia con la mia sorellina e i miei genitori. Approdammo a Mosca, da lì Stalin ci spedì in Uzbekistan. Era il 1940, e di quella spaventosa odissea ricordo ovviamente la fame, o meglio, l’insopportabile dolore fisico che provocava la fame. Ma quello che mi affliggeva maggiormente era sentire che non eravamo mai i benvenuti. Ogni volta che arrivavamo in un villaggio, venivamo arrestati da una pattuglia dell’Armata rossa, e i soldati ci urlavano: «Tornatevene da dove venite». Ma tornare indietro, per noi significava finire in una camera a gas e bruciare in un forno. A questo ho pensato appena ho saputo della spaventosa sciagura di Lampedusa. Come allora la mia famiglia, anche gli africani che sono morti ieri non potevano tornare indietro. I disgraziati che arrivano dall’Africa sulle carrette del mare, mi ricordano anche un’altra tragedia alla quale ripenso spesso.
Siamo nel 1938, e decine di migliaia di ebrei cominciano a fuggire dalla Germania nazista, dalla Cecoslovacchia già annessa da Hitler e dall’Austria. Ma nessuno li vuole. La Società delle Nazioni organizza allora una conferenza a Evian per decidere che cosa fare di questi rifugiati.
Un solo Paese al mondo è pronto a riceverli, la Repubblica domenicana! Gli Stati Uniti dicono che non possono superare la loro quota di immigrati, la Gran Bretagna non voleva che questi ebrei raggiungessero la Palestina, la Francia ospitava già troppi ex repubblicani spagnoli, l’Italia non si pronunciò neanche.
La prima domanda che sorge spontanea è la seguente. Quali progressi ha compiuto l’umanità dal 1938 a oggi? E la risposta è purtroppo una sola: non ne abbiamo compiuto alcuno.
Certo, davanti alla strage di Lampedusa, tutti s’indignano o si dicono sconvolti da tanto orrore, il Papa per primo. C’è un’altra domanda alla quale dobbiamo subito dare una risposta. Che cosa possiamo fare per impedire che ciò avvenga di nuovo. Come fermare queste migrazioni dall’Africa di chi fugge guerre tra clan, conflitti religiosi, corruzione, disoccupazione, carestie? È la pulsione vitale degli africani che li spinge a lasciare il loro inferno: lo fanno attraversando a piedi il deserto del Sinai diretti verso Israele, o mettendosi nelle mani dei mercanti di morte che li caricano su vecchi pescherecci per arrivare dall’altro lato del Mediterraneo.
Che fare, allora? Come prima cosa, credo che sarebbe indispensabile trascinare davanti alla Corte penale internazionale quei leader africani responsabili dei disastri umanitari che affliggono il Continente nero. Se il mondo avesse potuto fare lo stesso con Hitler, quando questi decise di conquistare l’Europa, milioni di vite sarebbero state risparmiate. Come secondo punto, andrebbero riuniti i Paesi più ricchi del pianeta per dichiarare d’urgenza un piano Marshall per l’Africa, controllato ovviamente dai donatori, e che stabilirebbe che chi sfrutta le risorse locali dovrà impiegare lavoratori africani (e non come fa Pechino, per esempio, che nelle enormi regioni che ha acquistato in Congo, Zambia o Angola importa mano d’opera dalla Cina). Infine, dovremmo organizzare una nuova conferenza di Evian, dove tenendo a mente quanto accadde nel 1938, i Paesi più sviluppati potranno dividersi quei migranti che continueranno ad arrivare in Europa, in attesa che si concretizzino le iniziative più virtuose per salvare il Terzo e il Quarto mondo.
I più pessimisti diranno che queste sono soluzioni utopistiche. Ma quando avvengono tragedie di questa portata ogni soluzione può sembrare tale.
L’importante è reagire. Il mondo non ha mosso un dito per salvare i rifugiati armeni che fuggivano dal genocidio turco, né gli ebrei dalla shoah, né i cambogiani massacrati dai khmer rossi o i tutsi fatti a pezzi dagli hutu in Ruanda.
L’Occidente deve rendersi conto che agire è nel suo proprio interesse, perché prima o poi, anche se molti migranti continueranno a morire per strada, saranno sempre più numerosi quelli che arriveranno nel nostro mondo ricco. E poi, siamo tanti su questo pianeta, più di sette miliardi di umani. Che ci vuole a spartirsi quel milione di rifugiati che provengono dai Paesi più poveri? Che ci costa nutrirli, scaldarli, offrire loro un tetto sotto cui rifugiarsi per evitare che muoiano annegati o bruciati sui barconi dei mercanti di morte.
Dall’Uzbekistan, alla fine della guerra sono finalmente arrivato a Parigi. Ho cominciato a conoscere la libertà imparando il francese. Ancora oggi, uso questa lingua nella speranza di far qualcosa per la libertà degli altri. Anche perché non dimenticherò mai l’orrore che si prova quando fuggi dall’inferno credendo di trovare il paradiso, ma è in un altro inferno in cui ti trovi. Proprio come è accaduto ieri a quei poveri disgraziati.
L’INFERNO DEI PROFUGHI DEL CORNO D’AFRICA
Intervista a Don Mussie Zerai, sacerdote eritreo presidente dell’agenzia Habeshia, agenzia per la cooperazione e lo sviluppo.
– 18 settembre 2012 – Pubblicato in: ALTRIMONDI
Continuano a scappare ogni anno. A centinaia. A migliaia. Dall’intero Corno d’Africa sconvolto dalla guerra e dalla fame. Soprattutto dall’Eritrea e dalla Somalia. Sono quasi tutti giovani: ragazzi, ragazze, non di rado coppie con i figli piccoli, ma sempre più spesso anche bambini di 10-14 anni, da soli. I campi profughi dell’Etiopia e del Sudan sono la prima tappa. Il primo rifugio da cui puntare verso l’Europa. Ma poi lì, nei campi, l’attesa si prolunga per anni. Tanto da sembrare infinita: un tunnel nero senza uscita. E allora molti, spesso i più ardimentosi, tentano il tutto per tutto per bussare alla porta dell’Occidente e chiedere asilo come rifugiati o perseguitati politici. Ma di mezzo ci sono mille ostacoli: chilometri di piste infinite nel deserto e di strade sterrate su camion e bus ansimanti, stracarichi; le retate della polizia, le razzie dei trafficanti di schiavi e di organi umani, l’ostilità o comunque la diffidenza dei governi dei paesi da attraversare prima di arrivare sulle sponde meridionali del Mediterraneo. Poi il mare, centinaia di miglia su vecchi pescherecci malandati, carrette ormai buone solo per questa tratta di disperati. Non c’è altra via: le frontiere blindate della “fortezza Europa” impediscono di salire su un traghetto di linea o su un aereo e obbligano a questa sfida per la libertà e la vita. Per chi “perde”, c’è la morte nel canale di Sicilia o nel deserto. C’è la prigione nei centri di detenzione in Libia o, peggio, le catene dei predoni del Sinai, che chiedono almeno 30 mila dollari di riscatto per la liberazione e non esitano a uccidere su ordinazione per alimentare il mercato dei trapianti clandestini. In confronto diventano una “fortuna” persino quei campi profughi tirati su alla meno peggio, che sembravano insopportabili: quei campi affamati e affollati ogni giorno di più.
Don Mussie Zerai, il sacerdote eritreo presidente dell’agenzia Habeshia, è stato tra i primi a denunciare questa emergenza umanitaria, giusto due anni fa. Ora è reduce da un nuovo viaggio in Africa, durato più di un mese, che lo ha portato in alcune delle zone più “calde” di questa fuga inarrestabile. A cominciare proprio da vari campi profughi, grandi come una città: Mayaini (oltre 14 mila ospiti) e Adiaharish (almeno 10 mila), in Etiopia, non lontano dal confine con l’Eritrea; e Kampala, in Uganda, con 11 mila rifugiati.
Tutti gli appelli alla comunità internazionale, perché si trovi una soluzione per queste migliaia di disperati, sono caduti nel vuoto. E la situazione generale continua a peggiorare. “Continua a peggiorare – spiega don Zerai – perché il flusso in entrata in questi campi aumenta di mese in mese, mentre la speranza di ottenere un visto “occidentale” come rifugiati si fa sempre più tenue. E senza speranza, per giovani che per il 95 per cento sono sotto i trent’anni, la vita nel campo diventa insopportabile. Solo in Etiopia entrano oltre mille migranti ogni 30 giorni. Dai campi, però, sono pochissimi quelli che riescono a ottenere un permesso per uscire legalmente ed approdare in Europa. Funzionano solo i ricongiungimenti familiari. Per gli altri non ci sono prospettive. E allora è facile cedere alle lusinghe delle organizzazioni criminali che promettono, anche se a caro prezzo, un passaggio relativamente sicuro in Europa o magari in Israele, che è visto come un prolungamento dell’Occidente sulla sponda sud del Mediterraneo. I risultati sono la tragedia ormai ben nota: traffico clandestino di esseri umani, migliaia di morti nel Mediterraneo, migliaia di detenuti nei lager libici, centinaia di profughi schiavi di bande di predoni beduini nel Sinai”.
Può fare un esempio, citare un episodio emblematico di questo inferno?
“Qualche giorno fa, il 12 settembre, mi ha telefonato un ragazzo eritreo dal Sudan. La sua è una storia incredibile, drammatica e paradossale allo stesso tempo. Circa tre anni fa è scappato da Asmara. E’ riuscito in qualche modo ad eludere la rigida sorveglianza interna e i posti di blocco della polizia, fino a raggiungere e a varcare il confine con l’Etiopia. Da qui, dopo alcuni mesi passati in un campo profughi, è entrato in Sudan, dove un ‘passatore’, in cambio di qualche migliaio di dollari, gli ha organizzato il viaggio attraverso la valle del Nilo e il Sinai, fino alle soglie di Israele. Con un po’ di fortuna è sfuggito alla caccia dei predoni beduini che trafficano in essere umani e a superare la frontiera, ma la polizia israeliana lo ha intercettato quasi subito e arrestato. Ha trascorso in carcere quasi un anno. Lui dice di essere stato anche picchiato duramente. Poi si è sentito male: gravi problemi di cuore. Problemi confermati dal medico di un ospedale israeliano. A quel punto, mi ha detto, è scattata l’espulsione: legato, imbavagliato e scortato da un paio di agenti, è stato caricato di forza su un aereo della Ethiopian Airlines e spedito ad Addis Abeba. Come clandestino fuggito dall’Etiopia, nonostante lui insistesse di essere in realtà eritreo. Proveniente cioè da un paese soggiogato da una ferrea dittatura militare. Una volta sbarcato e consegnato alla polizia di frontiera etiopica, ha raccontato la sua storia ed è stato di nuovo mandato in un campo profughi. Non è rimasto lì a lungo: ha tentato la sorte un’altra volta, passando clandestinamente il confine col Sudan. Ma, tempo pochi giorni, una pattuglia lo ha individuato e arrestato. Non solo: quando hanno saputo che era stato in Israele, lo hanno accusato di essere una ‘spia dei sionisti’ e pestato a sangue. Qualcuno gli ha dato il mio recapito e mi ha chiamato. Non sa cosa fare: in Eritrea rischia la fucilazione, in Etiopia non può tornare, in Sudan non può restare, ma non c’è alcun paese disposto ad accoglierlo. Io gli ho consigliato di rivolgersi alla sede di Karthoum del Commissariato Onu per i rifugiati. Ora, come agenzia Habeshia, stiamo contattando anche noi il Commissariato perché si interessi al suo caso”.
Ma come si vive nei campi? Come passano le giornate di attesa i profughi?
“Si tratta di campi quasi di fortuna. Buona parte degli alloggi sono costruiti dai rifugiati stessi. Baracche, più che casupole, fatte di materiali di risulta: legno, fango, pietre, paglia… E anche garantire il cibo sufficiente, almeno ai bambini, diventa un problema. Quasi un lusso. Ad ogni ospite l’organizzazione del World Food Programme distribuisce ogni mese 15 chili di grano, uno di zucchero, un litro d’olio, qualche saponetta e poco altro. Se non si riesce ad ‘arrotondare’ con un lavoro fuori del campo (braccianti agricoli, manovali in un cantiere, ecc.) o se non arrivano aiuti dall’esterno, magari da parenti e amici, si deve andare avanti solo con questo. E’ drammatico. Ho visto famiglie disperate, con una decina di figli piccoli. Tutti denutriti, affamati. Proprio i bambini sono il primo problema. Habeshia sta contribuendo a un programma per aiutarli, affidato all’Agenzia dell’Onu per i rifugiati e in collaborazione con varie Ong. L’obiettivo è fornire almeno a tutti i piccoli fino a 7 anni di età un pasto ‘vero’ al giorno, una dieta adeguata a strapparli alla denutrizione e all’inedia. Ma altrettanto grave è la condizione degli adolescenti, per i quali non c’è soltanto il problema della povertà e della fame”.
Che cosa intende? Qual è in generale la vita degli adolescenti nei campi?
“I profughi minorenni, i ragazzini tra i 14 e i 18 anni, sono forse quelli che rischiano e soffrono di più. Specialmente le ragazze e soprattutto se, come capita quasi sempre, sono scappati da soli, senza altri familiari o amici maggiori. La loro è già di per sé un’età difficile, inquieta. Occorrerebbe motivarli, dargli una prospettiva di futuro, dei valori. Invece sono abbandonati a se stessi. Con l’ossessione quotidiana di trovare il mangiare per sopravvivere. Nei campi manca qualsiasi forma di controllo e tutela. Capita così che ragazzine appena quattordicenni comincino a frequentare bar e locali nei dintorni, di giorno e anche, anzi forse soprattutto di sera e di notte. Bar e locali dove passano individui di ogni tipo e dove spesso vengono adescate e violentate: rapite e vendute come prostitute o magari sul mercato dei trapianti clandestini. Ma anche all’interno dei campi non mancano violenze e stupri, specie se queste ragazze vivono sole nella loro baracca. Indifese. Non serve neanche denunciare la violenza subita. Per avere qualche speranza che lo stupratore venga arrestato, occorre che la polizia o comunque qualcuno lo sorprenda in flagranza. Altrimenti gli basta dichiarare che la ragazza era consenziente e la cosa in pratica finisce lì: nessuno si prende la briga di indagare. Peggio: la vittima subisce minacce e intimidazioni o rischia addirittura di essere pestata e violentata di nuovo. Per punizione”.
Può citare qualche episodio specifico?
“Certo. Un caso di stupro all’interno di un campo mi è stato raccontato proprio in occasione del mio ultimo viaggio in Etiopia. Riguarda una sedicenne, arrivata in quel campo dall’Eritrea insieme alla sorella, di due anni più grande. Si erano sistemate in una piccola baracca, confusa tra le altre. Settimane e mesi consumati nell’attesa di un visto per poter emigrare. Poi la sorella ha conosciuto delle persone che l’hanno convinta a diventare pentecostale. Lei, invece, la più piccola, cristiana copta, ha rifiutato, respingendo le insistenze sia della sorella che dei suoi amici. Finché alcuni giovani si sono presentati nel suo alloggio, l’hanno rapita e battezzata per forza. ‘Ho cercato di ribellarmi, ho gridato mentre mi portavano via. C’era tanta gente nel campo, ma nessuno mi ha aiutato’, mi ha raccontato. Riportata nella sua baracca dopo la ‘conversione’, non ha voluto restare: ha abbandonato la sorella ed è andata ad abitare in un altro alloggio, dichiarando a tutti che quella conversione forzata non aveva alcun valore: era ancora di religione copta. Questa ribellione non le è stata perdonata. Alcuni sconosciuti hanno fatto irruzione nella sua nuova ‘casa’ e l’hanno stuprata. Per punizione, le hanno detto. Lei non si è arresa. Ha informato la polizia del campo, raccontando tutti gli abusi subiti. Ma è stato inutile. E’ minorenne: i poliziotti le hanno detto che la sua denuncia doveva essere firmata anche dalla sorella maggiore. La quale ha negato tutto”.
Ma quali prospettive ci sono, allora, per questi giovani? E cosa si può fare?
“L’unica prospettiva concreta è dare un senso alla loro permanenza nei campi, perché non cedano alle lusinghe di “guide” pronte a tradirli e a venderli. E questo si può ottenere solo con due iniziative, che vanno di pari passo. Convincere l’Unione Europea a rendere meno rigide le norme per l’ingresso di profughi e richiedenti asilo, stabilendo magari delle quote annuali certe, e poi, contemporaneamente, riempire il vuoto di quei lunghissimi mesi, anni di attesa con lo studio e il lavoro. Il primo è un compito dei governi occidentali: della politica, dunque e, per indurla a intervenire, occorre la mobilitazione di quanta più gente possibile, creando un vasto movimento d’opinione. Il secondo obiettivo si può attuare con poca spesa e in breve tempo. Anzi, già sono stati raggiunti dei risultati. Si tratta di organizzare scuole dentro o fuori dei campi: corsi professionali, ad esempio, per ‘formare’ meccanici, falegnami, idraulici, tecnici, infermieri, che possano poi trovare un impiego in Europa o, ancora meglio, se e quando potranno tornare nel loro paese. Dovrebbero bastare 70 dollari al mese per ogni alunno, incluse le spese di vitto e alloggio. I diplomati, invece, potrebbero frequentare l’università. L’Etiopia, nonostante i suoi gravi problemi economici interni, ha abbandonato l’atteggiamento di chiusura iniziale e sta facendo molto: nell’ultimo anno ha garantito mille borse di studio da 100 dollari, sufficienti per un mese di studio, sempre inclusi vitto e alloggio. Il presidente Meles Zenawi è morto da qualche settimana, ma il nuovo governo ribadirà certamente il progetto. C’è l’impegno, inoltre, di rilasciare i permessi di soggiorno per studio ai ragazzi che riceveranno borse di studio dello stesso genere da altra fonte. Magari dai governi europei o da qualche Ong”.
C’è qualche speranza di attuare questo duplice programma?
“Guai se non avessimo speranza. Ma certo le condizioni di partenza, in Europa, non sono incoraggianti. Tutta la politica europea, finora, ha pensato solo ad alzare barriere nei confronti di profughi e migranti, giungendo persino a delegare il controllo dell’emigrazione ai governi e alle polizie del Nord Africa. In particolare l’Italia, che ha di recente rinnovato gli accordi con la Libia. Accordi al buio, firmati senza nemmeno pretendere la possibilità di accesso libero e ispezioni, da parte delle commissioni Onu o europee, nei centri di detenzione dei profughi respinti. Eppure è noto che la Libia non ha mai firmato nessuna convenzione internazionale sui diritti umani e meno che mai quella sul trattamento di richiedenti asilo ed emigrati”.